Smart working da pandemia in Veneto, una bolla che si è sgonfiata
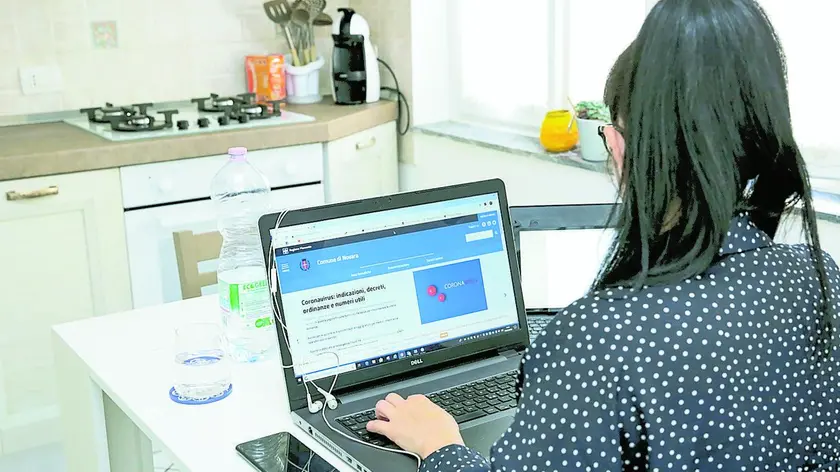
VENEZIA. L’orizzonte del mercato del lavoro è avvolto da una fitta nebbia. Al momento, e fino alla metà di novembre, i provvedimenti governativi hanno imposto uno stop ai licenziamenti da parte delle imprese, ipotizzando così di rimediare ai disagi sociali che la perdita del lavoro crea. Una volta di più siamo di fronte a un pannicello caldo, a un provvedimento di natura passiva che sposta solo più in là una situazione potenzialmente esplosiva. Ma che comunque arriverà.
È evidente che scontiamo una serie di mancate scelte che dovevano essere prese negli anni passati sullo sviluppo delle politiche attive per il lavoro (come formazione continua, servizi di orientamento professionale) e un riordino degli ammortizzatori sociali utile a non disperdere risorse e a meglio finalizzare gli interventi di sostegno a chi si trova in difficoltà.
Come spesso accade nel nostro paese, ci troviamo a dover fronteggiare situazioni problematiche non essendo preparati, non avendo progettata e realizzata una riforma prima. Un po’ perché contiamo sulla nostra tradizionale flessibilità, l’inventiva, perché sotto stress diamo il meglio di noi e facciamo affidamento alla “buona stella”. Ma, soprattutto, perché le odierne classi dirigenti sono generalmente inclini alle sirene del consenso immediato, a cercare soluzioni semplici a problemi complessi, agli slogan che durano lo spazio di qualche ora. Che anche sui temi del lavoro e sulle ricette per salvaguardare l’occupazione non sono mancati.
Chi ha rinverdito l’antico “lavorare meno, lavorare tutti”, altri hanno proposto riduzioni di orari di lavoro a parità di salario: soluzioni che affondano le radici negli ’70 e ’80 del secolo scorso, ma che non considerano il mutato contesto produttivo, il problema della produttività delle nostre imprese e il debito pubblico monstre che grava sul paese. Più di recente è pure emersa la proposta di utilizzare parte delle risorse del Recovery Fund per compensare lo stipendio a fronte di una diminuzione di orario di lavoro.
Ma la palma dell’idea più gettonata è quella diffusione dello smart working quale soluzione principe per salvaguardare i posti di lavoro. Già su queste colonne ho evidenziato come quello che abbiamo conosciuto durante il periodo di chiusura delle attività economiche non fosse smart working, ma telelavoro, lavoro da casa o da remoto, perché lavorare in modalità “smart” non prevede orari di lavoro, né luoghi fisici prestabiliti, oltre alla connettività che tutti abbiamo sperimentato essere ancora debole. E di come le ricerche sui lavoratori dipendenti (Community Research&Analysis) abbiano indicato una sua diffusione a macchia di leopardo, con grandi disparità di utilizzo.
La recente rilevazione dell’Istat sulle imprese italiane e gli strumenti messi in campo per fronteggiare la pandemia offrono ulteriori spunti di riflessione sull’utilizzo del lavoro a distanza. Fra i molti dati vale la pena soffermarsi su alcuni per farsi un’idea più concreta del fenomeno. Innanzitutto, dove potrebbe essere realistico utilizzare il lavoro da remoto, in virtù della sua tipologia? Un quinto delle imprese (21,9%) lo ritiene plausibile al proprio interno e tale opinione è concentrata solo in alcuni settori, nell’ordine: servizi di informazione e comunicazione (76,1%), forniture di energia elettrica e gas (68,7%), attività finanziarie e assicurative (52,6%) e professionali e scientifiche (62,7%), istruzione (53,7%) e attività immobiliari (42,1%). Tutti ambiti dove l’utilizzo delle tecnologie digitali era già in buona misura utilizzato ancora prima della propagazione della pandemia e, quindi, risulterebbe più facilitata una riorganizzazione del lavoro. In secondo luogo, com’è facile intuire, molto dipende dalla dimensione delle imprese. Se solo il 21,9% delle micro-imprese (fino a 9 addetti) intravede possibile il lavoro a distanza, tale soglia aumenta al 67% fra le più grandi (oltre 250 addetti). Dunque, anche dal punto di vista ipotetico, il lavoro da remoto riguarderebbe una parte minoritaria dell’universo aziendale.
In terzo luogo, quante saranno le imprese che hanno modificato i propri assetti organizzativi adottando il lavoro a distanza? Prima del lockdown solo l’1,2% degli occupati, ovvero circa 154mila persone sui quasi 13 milioni di lavoratori, lavorava in remoto. Durante la chiusura (marzo-aprile) tale quota sale all’8,8%, concentrati soprattutto nei settorI delle attività finanziare e assicurative (48,8%), nei servizi a supporto delle imprese (36,7%), nell’assistenza sociale (33,0%), piuttosto che nella attività professionali (25,7%) e immobiliari (26,1%). In altre parole, la smaterializzazione del posto di lavoro ha riguardato in particolare una parte del terziario e dei servizi.
Nel bimestre della riapertura (maggio-giugno), il posto di lavoro torna a materializzarsi e la quota di occupati che continuano a lavorare da casa scende al 5,3%. In altri termini, le imprese hanno riassorbito una parte degli occupati entro le mura delle aziende, riducendo il novero dei lavoratori a distanza, ma mantenendo comunque una quota superiore a quanto avveniva prima della pandemia.
La bolla del lavoro da remoto si è sgonfiata, ma non per tutte le tipologie di aziende: il 33,2% dei lavoratori dell’informazione e comunicazione opera da casa, e così pure il 27,7% di quelli dell’istruzione e il 20,0% dei professionisti. Inoltre, questi processi riorganizzativi investono le imprese più grandi (25,1%, oltre 250 addetti), mentre sfiorano solo marginalmente le più piccole (4,5%, fino a 9 addetti). Sotto il profilo territoriale il Nord Ovest è l’area d’impresa più disponibile alla riorganizzazione (6,6%) seguita dal Centro (5,8%), mentre più riluttanti risultano quelle del Nord Est (4,7%) e del Mezzogiorno (4,0%).
In attesa che si materializzi il vero smart working, anche il lavoro da remoto non è “la” ricetta valida per tutte le imprese e i lavori. In particolare, per sistemi produttivi caratterizzati dalle piccole e micro-dimensioni. Ciò non toglie non debba essere perseguita una sua diffusione, ma richiede investimenti organizzativi, gestionali e soprattutto culturali che necessitano di risorse e tempi lunghi. Soprattutto di attori associativi e formativi che investano nella educazione ai nuovi paradigmi dello sviluppo sostenibile. —
Riproduzione riservata © il Nord Est





